
Ex Ilva: la partita più delicata si gioca sul fronte industriale
Punto di partenza e prospettive 2021 per la Newco in corso di definizione
30 novembre 2020
Si è provato con il commissariamento prima, con la cessione al privato sotto l’occhio vigile dello Stato poi. Ora si tenterà di farlo con la partecipazione diretta dello Stato con il privato. Stiamo parlando del rilancio dell’ex Ilva di Taranto e soprattutto delle speranze che ogni nuova fase porta con sé, al netto delle incognite che purtroppo, sinora, hanno reso non risolutivo ogni intervento.
Di seguito, al netto di eventuali cigni neri non prevedibili, proveremo ad indicare il punto di partenza e valutare se le stime alla base dell’intesa rispecchino le attese di sviluppo del mercato.
Riassumendo al massimo, l’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal arriverà probabilmente il 10 dicembre e vedrà, in una prima fase, a fronte di un pagamento di 400 milioni di euro, la cessione del 50% delle quote del capitale sociale all’azienda statale.
Eredità e punto di partenza
Facciamo però un ulteriore passo indietro, e partiamo dall’eredità che la Newco pubblico-privata riceverà da cinque anni di gestione commissariale e due anni di gestione privata, anche se il 2020 è stato un anno molto anomalo rispetto ai precedenti.
La nuova azienda eredita impianti provati dal punto di vista produttivo: sono state numerose nel corso degli ultimi due mesi le denunce da parte dei rappresentanti dei lavoratori della carenza di condizioni di sicurezza per gli operatori in alcune aree del sito a causa di manutenzioni mancanti o insufficienti. Rispetto al 2012 invece è sensibilmente migliorato l’impatto ambientale dello stabilimento. Lo testimoniano le coperture dei parchi minerali, che sette anni fa erano solo un sogno e che invece nel prossimo anno saranno ultimate, proteggendo, si spera definitivamente, il quartiere Tamburi dalle dispersioni di polveri nei windy days. Il prossimo anno dovranno essere completate anche le chiusure dei nastri trasportatori di materie prime, che sono nell’ordine dei 70 chilometri complessivi. Da non dimenticare i vari filtri posti sui camini degli altiforni, e i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, solo per citare alcuni interventi. Nell’ultima relazione commissariale disponibile sul sito di Ilva in As, risalente all’ultimo trimestre 2019, si leggeva che lo scorso anno l’Amministrazione Straordinaria aveva speso per interventi ambientali oltre 530 milioni di euro, a cui se ne aggiungono altri 67 milioni a pagamento diretto di ArcelorMittal. Il colosso siderurgico, nonostante le difficoltà del 2020, ha inoltre investito altri 280 milioni di euro (anche se in questo caso non sono solo investimenti ambientali) portando il totale delle spese a quasi un miliardo di euro. Dal punto di vista ambientale, quindi, per rispettare il piano Aia l’azienda dovrebbe essere a buon punto.
Un aspetto su cui invece si dovrà lavorare saranno i 3,3 milioni di tonnellate di produzione con cui l’azienda chiuderà il 2020. I limiti produttivi con cui Ilva si è trovata a confrontarsi negli ultimi anni sono infatti stati il principale tallone d’Achille dell’azienda, dovuti sì ad una serie di elementi congiunturali, come la crisi dell’automotive e la riduzione dell’output a seguito della pandemia, ma anche a difficoltà giudiziarie come il contenzioso sul mancato adeguamento di Afo 2 alle prescrizioni imposte dopo il tragico incidente del 2015. Afo 2 che tra l’altro, calcolando il ciclo di durata medio di un impianto, sarebbe arrivato quasi a fine vita. Sul fronte della durata anche gli altri impianti non sarebbero messi meglio: Afo 4 ha all’orizzonte circa un anno ulteriore di attività mentre per Afo 1 l’orizzonte è nell’ordine di circa tre anni. In pratica al massimo in tre anni quindi tutti gli impianti dell’azienda dovranno essere sottoposti o ad un revamping completo o a manutenzioni massicce.
Seguendo stime che possiamo definire standard nel settore, un revamping completo di un altoforno, a piena produzione, viene ammortizzato in 14 anni, mentre una manutenzione massiccia necessita di 8 anni, elementi non di certo secondari nell’elaborazione di un piano industriale. Senza contare poi che il motore produttivo, gli altiforni, dovrà comunque essere supportato dal resto delle parti meccaniche: se infatti il motore è ottimo, ma cambio, trasmissione, sospensioni e pneumatici di un’auto sono usurati, non si sarà in grado di poter rendere al massimo. Quindi il nuovo piano industriale dovrà prestare attenzione ad acciaierie, tubificio, treno lamiere, eccetera, al fine di dare il corretto supporto ad un’area produttiva perfetta, ambientalmente compatibile e dotata degli ultimi ritrovati tecnologici in termini di produzione base.
Il piano e il mercato
Guardando al piano presentato da ArcelorMittal lo scorso 5 giugno (l'unico aggiornato con scenari post Covid), che dovrebbe essere stato utilizzato come base per l’elaborazione del nuovo documento, la multinazionale prevede in marcia senza stop Afo 1 e Afo 4 almeno fino al 2025, mentre Afo 2 verrà definitivamente spento a metà 2024 per non essere più acceso. Lo stop di Afo 2 dovrebbe coincidere con l’avvio del forno elettrico, uno per Mittal e due per il Governo, anche se su questo punto bisognerà attendere le nuove documentazioni per capire da quale parte penderà la bilancia. Il piano di Mittal prevedeva 3,4 milioni di produzione nel 2020, e una risalita dal 2021 a 5,3 milioni di tonnellate per poi raggiungere nel 2025 i 6,5 milioni di tonnellate, che per il Governo dovranno essere 8 grazie all’inserimento di un nuovo forno elettrico. Dal punto di vista del mix produttivo l’intenzione per il prossimo anno è di realizzare 1,966 milioni di tonnellate di coils neri, 250mila tonnellate di decapato, 384mila tonnellate di freddo, 1,586 milioni di tonnellate di rivestito, 269mila tonnellate di lamiere da treno, 134mila tonnellate di banda stagnata e 211mila tonnellate di tubi strutturali.
Un mix compatibile con le stime sul recupero del mercato siderurgico nel 2021. Gli ultimi dati di Eurofer, illustrati lo scorso 28 ottobre dal Director of Market Analysis and Economic Studies Alessandro Sciamarelli, sebbene con il beneficio del dubbio dato dalla fase di incertezza attuale, indicano che le costruzioni dovrebbero recuperare un 5% rispetto al 2020, la meccanica un 7,4%, l’automotive un 18,1% e gli elettrodomestici un 4,6%. Dati che portano l’indice pesato dell’output dei settori utilizzatori ad un recupero medio del 8,2%.
Aspettative e produzioni quindi abbastanza armonizzate per poter adeguare il recupero dello stabilimento alla crescita di domanda. Questo però era lo stato prima che il sito italiano venisse commercialmente scorporato dalla casa madre, ottenendo un’autonomia di movimento che potrebbe andare ad incidere sulle stime di vendita.
Volutamente in questo articolo non si è affrontato uno dei nodi base della trattativa in corso, quello occupazionale, un nodo che incide in maniera significativa sulla sostenibilità economica di quanto descritto. Per il 2020 ArcelorMittal ha fatto abbondante ricorso ad ammortizzatori sociali, un atteggiamento però che i sindacati hanno annunciato di non voler più assecondare a meno che non vi sia prima un confronto sulle prospettive industriali di eventuali riduzioni temporanee di personale.
Insomma la situazione appare molto liquida e fino a quando il piano industriale aggiornato non sarà ufficializzato sarà anche molto complesso fare stime sulla sostenibilità dell’operazione, operazione che tra l’altro potrebbe persino beneficiare degli aiuti europei per fornire maggiore ossigeno nella fase di transizione energetica. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi la vera partita inizia oggi, ma solo a febbraio con la firma definitiva si potrà fare una valutazione complessiva dell’operazione.
Davide Lorenzini
siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026

20 febbraio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'ultimo siderweb on air e lo ...
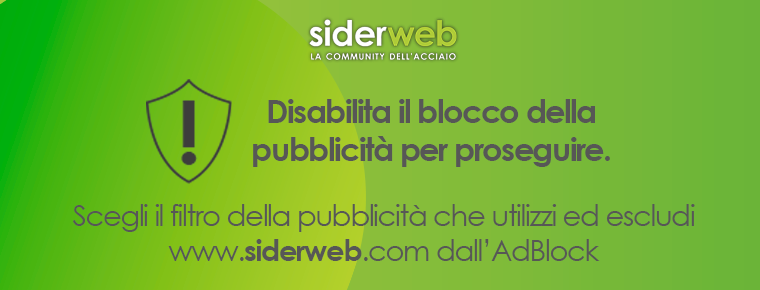


















Lascia un Commento